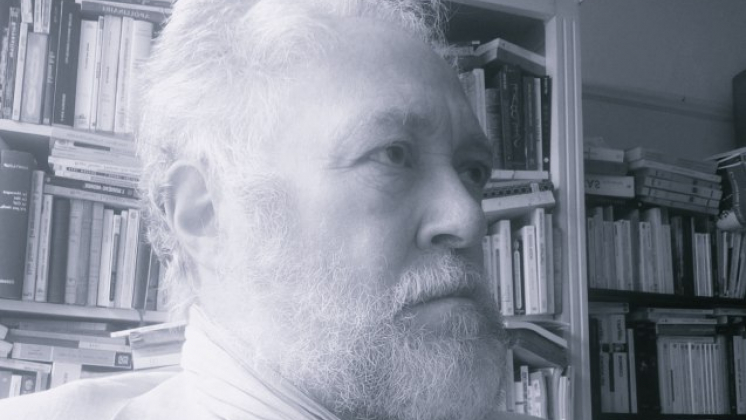Robert Steuckers: Armin Mohler, non come lettore di Jünger ma come lettore di Schmitt, è un gollista, proprio in nome dei principi della sua rivoluzione conservatrice.
Quando Armin Mohler scrisse il suo libro, La rivoluzione conservatrice in Germania 1918-1932, lasciò un'eredità significativa che sarebbe stata oggetto di dibattito per molto tempo. Mohler, che un tempo era stato segretario di Ernst Jünger, è una delle figure chiave del rivoluzionarismo conservatore. Abbiamo discusso di Mohler con Robert Steuckers, figura di spicco della Nuova Destra europea e fondatore del movimento Synergies européennes.
Potrebbe parlarci di Armin Mohler e del suo libro La rivoluzione conservatrice in Germania 1918-1932? Utilizzando il concetto ancora controverso di “rivoluzione conservatrice”, cosa intendeva esattamente e quale quadro di pensiero stava cercando di costruire?
Ho conosciuto Armin Mohler principalmente attraverso conversazioni telefoniche, soprattutto nel contesto della rivista Criticon, con sede a Monaco, diretta dal barone Caspar von Schrenck-Notzing. Nel 1978-79, per la rivista GRECE-Bruxelles diretta da Georges Hupin, ho riassunto il famoso dibattito tra Armin Mohler e Thomas Molnar, filosofo cattolico e aristotelico-tomista. Questo dibattito riguardava la disputa sugli universali: Molnar difendeva gli universali nella tradizione tomista, che secondo lui dovevano essere riportati alla loro pienezza per fermare la decadenza. Mohler, invece, riteneva che gli universali fossero degenerati in banalità generalizzanti che non consentivano più alcun dinamismo politico. Si presentava, forse in modo un po' goffo, come un “nominalista” attento a tutte le particolarità – nazionali o vernacolari – in opposizione alle “generalità” (die All-Gemeinheiten, come le chiamava lui) dell'ideologia liberale occidentale. Molnar riteneva che questo liberalismo avesse dissolto tutte le solide fondamenta della vita comunitaria per promuovere individualismi “occasionalisti” (Carl Schmitt). Questo riassunto, messo su carta da un oscuro giovane studente di Bruxelles, diede il via a un intero dibattito all'interno dei circoli francofoni della «nuova destra», un dibattito che da allora si è affievolito nel corso dei decenni, poiché questo ambiente, principalmente parigino, ha ormai dimenticato l'opera di Mohler, che andava ben oltre i temi della Rivoluzione Conservatrice.
In seguito, Mohler si interessò al lavoro didattico dello storico israeliano Zeev Sternhell su “La destra rivoluzionaria” (“La droite révolutionnaire”) in Francia, emersa dopo la sconfitta delle armate di Napoleone III nel 1871 e ossessionata dal desiderio di vendetta. Questo periodo, segnato in particolare dall'avventura del generale Boulanger, che architettò un colpo di Stato militare e popolare, aveva interessato anche Ernst Jünger durante gli anni più caldi della Repubblica di Weimar. Jünger riteneva che una presa di potere con la forza, come quella di Boulanger, fosse un modo più “pulito” e “nobile” di conquistare il potere rispetto alla corruzione di una democrazia basata sui partiti, come quella che era salita al potere dopo gli eventi del novembre 1918. Mohler scrisse quindi una sintesi particolarmente didattica del libro di Sternhell, La droite révolutionnaire, per la rivista Criticon. Elfrieda Popelier, allora impegnata nelle attività del GRECE-Bruxelles, si occupò della traduzione di questo testo, e io decisi di pubblicarlo a Ginevra sotto forma di un corposo opuscolo, accompagnato da un testo del giurista marsigliese Thierry Mudry (su alcuni aspetti interessanti dell'opera di Jean-Jacques Rousseau, secondo Noel O'Sullivan) e dai miei commenti sull'opera di Sternhell. Questi commenti, tra l'altro, erano tratti dal copione di una conferenza che tenni a Colonia presso il Gesamtdeutscher Studentenverband (GDS) su iniziativa di due amici ormai scomparsi, Günter Maschke e Peter Bossdorf. Quest'opera ebbe un discreto successo e fu ristampata numerose volte.
All'epoca, il libro Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932 era quasi introvabile e non era stato ristampato. Solo nel 1988-89 l'editore “Wissenschaftliche Buchgesellschaft” ne pubblicò una nuova edizione, che io a mia volta riassunsi, questa volta per la mia rivista, Vouloir. Anche il direttore della rivista Tekos di Anversa recensì l'opera, aggiungendo note comparative tra gli autori conservatori tedeschi e gli autori fiamminghi e olandesi che erano loro vicini o da loro ispirati. Tradussi anche questa ampia recensione e la integrai con un apparato di note per i lettori francofoni.
Per ricostruire il contesto in cui è emersa questa importantissima opera sulla rivoluzione conservatrice, diciamo che quando Mohler era segretario di Ernst Jünger, a partire dal 1949 – anno in cui furono create le due repubbliche tedesche e la NATO – i due uomini dovettero discutere delle idee e dei pensieri fertili che la Germania aveva generato nel corso dei decenni, almeno a partire dalla costituzione del Secondo Reich di Bismarck. La sconfitta del 1945 sembrava rendere obsoleto qualsiasi progetto di restaurazione basato su tali idee, e in particolare quelle che avevano animato tutti i dibattiti tra il 1918 e l'ascesa al potere di Hitler. Era quindi necessario fare un inventario di tutte queste idee affinché ne rimanesse traccia, con la speranza che nuove menti audaci le cogliessero, le aggiornassero e le traducessero in una nuova realtà dopo un possibile crollo del sistema messo in atto dai servizi americani.
Nelle note sparse e frammentarie del suo diario risalenti al periodo in cui era segretario di Ernst Jünger (cfr. AM, Ravensburger Tagebuch – Meine Jahre mit Ernst Jünger, Karolinger Verlag, Vienna, 1999), Mohler spiega in modo molto succinto come gli è venuta l'idea per questa tesi di dottorato. Quando fece domanda per assumere il ruolo di segretario di Ernst Jünger, Mohler ricevette da lui questa ingiunzione: “Insisto affinché tu prima finisca i tuoi studi”. Ernst Jünger non voleva approfittare di un idealista ingenuo che avrebbe sacrificato il proprio futuro per dedicarsi esclusivamente alla sua persona. Una saggezza che molti altri nel vasto movimento conservatore-rivoluzionario o neo-destra non avrebbero poi mantenuto. Armin Mohler chiese quindi al tranquillo filosofo Karl Jaspers di sponsorizzare la sua tesi di dottorato. Jaspers accettò, anche se Mohler aveva avviato una polemica contro di lui nel testo della sua tesi. Jaspers gli chiese allora: “È vero che in una certa pagina lei polemizza contro di me?”. Mohler confermò e Jaspers rispose: “Noi filosofi spesso nutriamo serpenti nel nostro seno, ma presumo che in seguito non farai molto uso della filosofia...”. Mohler chiese allora a Jünger perché avesse attribuito tanta importanza alla stesura di questa tesi. La risposta: “Nessuna importanza, ma non volevo essere responsabile del fatto che tu non avessi conseguito il dottorato”.
All'epoca Ernst Jünger aveva abbandonato il radicalismo delle sue tesi politico-filosofiche degli anni Venti e Trenta (almeno fino al 1934). Dalla durezza ideologica dello scrittore nazional-rivoluzionario e “soldatesco”, era passato alla meditazione, scivolando verso posizioni tradizionaliste che avrebbero trovato espressione in una rivista straordinaria, Antaios, che da allora non ha avuto eguali nello spazio linguistico tedesco. Mohler, essendo più giovane, ricordava che durante la sua fuga dalla Svizzera (era originario di Basilea) dal gennaio al dicembre 1942, si era costretto a copiare a mano tutti gli articoli nazional-rivoluzionari di Jünger nelle biblioteche di Berlino. Il libro di riferimento del giovane Mohler era Der Arbeiter (Il lavoratore). Voleva riscoprire questo spirito ribelle ed esaltato, ostile ai sistemi liberali, nel suo capo (Der Chef). Quest'ultimo aveva appena completato un altro grande libro, Heliopolis. Mohler considerava quest'opera “non essenziale” rispetto a Der Arbeiter, il libro principale di Jünger negli anni '30. Mohler tenne quindi a mente le linee principali del Jünger nazional-rivoluzionario e considerò secondarie le idee sviluppate dalla pubblicazione di Heliopolis.
In Jaspers, nonostante le critiche che rivolse a questo buon filosofo protestante, Mohler individuò comunque un'idea essenziale: quella dei “periodi assiali” che scandivano e segnavano la storia. In questi periodi assiali emergono idee sconvolgenti che alterano la traiettoria pacifica delle civiltà che, poco prima della loro comparsa, si erano fossilizzate e rischiavano un declino irreversibile. Per Jaspers, Buddha, Socrate e Cristo avevano portato le necessarie idee sconvolgenti, rispettivamente nell'antica India, nella civiltà greca e nell'Impero Romano. Per Mohler, l'idea di un periodo assiale poteva essere applicata al nostro spazio civilizzazionale, soprattutto dopo il desiderio di Nietzsche di “rivalutare tutti i valori” (Umwertung aller Werte). La rivoluzione conservatrice tedesca racchiude in sé tutte le possibilità di trascendere i quadri politici stabiliti dall'Illuminismo e dalla Rivoluzione francese. In seguito, secondo Mohler, Sternhell dimostrò che i “rivoluzionari di destra” francesi, in particolare Jules Soury, Hippolyte Taine e Maurice Barrès (uno dei preferiti del nazional-rivoluzionario Jünger), coltivarono nei testi che scrissero tutti gli ingredienti per scuotere e sconfiggere l'ideologia borghese della Terza Repubblica, inaugurata dopo la sconfitta del 1871.
Per ragioni pratiche e data l'impossibilità di essere totalmente esaustivo, la tesi di dottorato di Mohler ha dovuto ridurre lo spazio-tempo delle sue indagini al periodo compreso tra il crollo del Reich guglielmino nel 1918 e l'ascesa al potere dei nazionalsocialisti nel gennaio 1933. Le idee dibattute tra il novembre 1918 e il gennaio 1933, tuttavia, non caddero improvvisamente dal cielo e hanno una genealogia che a volte risale agli “altri Illuminismi”, in particolare all'opera di Johann Gottfried Herder, o addirittura a quella di Hamann nel XVIII secolo. Ecco perché ha elogiato il lavoro di Sternhell su The Revolutionary Right, perché studiava un periodo particolarmente fertile per le sue critiche al liberalismo e alle All-Gemeinheiten, le generalità ossificanti che aveva generato nello spazio occidentale (e in misura molto minore in Russia, dove la critica all'occidentalismo si univa implicitamente alle opere dei rivoluzionari di destra francesi e, più tardi, ai conservatori-rivoluzionari e ai nazional-rivoluzionari tedeschi della Repubblica di Weimar, dove Arthur Moeller van den Bruck era il noto traduttore di Dostoevskij in tedesco).
La rottura tra Jünger e Mohler nel 1953 fu causata dall'autocensura di Jünger su alcuni dei suoi testi degli anni Venti e Trenta. Mohler voleva che fossero ripubblicati nella loro interezza e senza alcuna censura. A questo proposito, Mohler dichiarò: “Avevo protestato pubblicamente contro questa automutilazione che Jünger si era inflitto censurando i suoi scritti giovanili. Per il Maestro, quella era stata una lezione di troppo da parte del suo segretario”.
Da notare che, tra i molti altri compiti e incarichi, Mohler divenne nel 1961 segretario della Carl von Siemens Stiftung di Monaco di Baviera, carica che mantenne fino al 1985. In questa veste, patrocinò opere collettive che, per me, furono decisive nello sviluppo della mia visione metapolitica, in particolare quella intitolata Der Ernstfall. Poi Kursbuch der Weltanschauung e Der Mensch und seine Sprache (nel contesto dei miei studi universitari); infine, Die deutsche Neurose (sulla Germania dopo il 1945).
Politicamente, Mohler era chiaramente impegnato e non si dedicava alla “metapolitica da salotto” come alcuni dei suoi pseudo-ammiratori che lo citano ma non seguono le sue istruzioni. Così, con Franz Schönhuber (leader dei Republikaner), Hellmut Diwald (un rinomato storico che non esitava a scatenare formidabili controversie) e Hans-Joachim Arndt (un acuto critico della scienza politica americanizzata), fondò un “Deutschlandrat” (un “Consiglio tedesco”) a Bad Homburg, prima di sostenere i Republikaner di Schönhuber scrivendo gran parte del loro manifesto, il Siegburger Manifest (1985).
All'interno di questo movimento stesso, in quali correnti o tendenze distinte erano divisi i “rivoluzionari conservatori”?
Le correnti principali che dovrebbero essere ricordate oggi perché hanno ancora una certa rilevanza per i dibattiti attuali sono i “rivoluzionari nazionali”, la corrente ‘Völkisch’ (popolarista) e i “Jungkonservative” (Giovani Conservatori). Personalmente includerei il “movimento contadino” dello Schleswig-Holstein tra i nazional-rivoluzionari, poiché godeva del chiaro sostegno dei fratelli Jünger e di Ernst Niekisch. Poi, alcune correnti non direttamente politiche, nell'archeologia, nella linguistica e nella filologia, furono inizialmente escluse dai dibattiti dopo il 1945 e fino ai primi anni del XXI secolo, per poi tornare con forza quando la ricerca, soprattutto nell'archeologia preistorica o protostorica, ne rivelò la validità grazie alle nuove tecniche!
Della corrente “nazional-rivoluzionaria”, sia gli ammiratori che i detrattori ricordano essenzialmente gli eccessi (quelli che Jünger voleva cancellare nel 1953). Il linguaggio adottato era certamente rude, ma la nostra epoca recente, soprattutto dopo il Maidan di Kiev nel 2014 e lo sviluppo del gruppo di paesi BRICS, ha potuto scoprirvi le radici di molti problemi contemporanei. I nazional-rivoluzionari dell'era della Repubblica di Weimar concepivano la politica estera della Germania in modo molto diverso da quello dei liberali, dei cristiano-democratici e dei socialisti asserviti ai principali partiti dell'epoca. Per loro, la Germania non era un «paese occidentale»; l'Occidente, ai loro occhi, era limitato all'Inghilterra, a causa delle sue profonde fondamenta puritane e cromwelliane; alla Francia, con il suo aggressivo e rabbioso miscuglio ideologico repubblicano sterilizzante che schiacciò la Germania sconfitta esigendo riparazioni folli; e infine agli Stati Uniti con la loro politica estera wilsoniana e il loro desiderio di portare la Germania sotto il loro controllo offrendo piani di finanziamento e di ripresa (i piani Young e Dawes), accettati da una borghesia tedesca miope. Questa politica americana sarebbe stata perpetuata dal Piano Marshall dopo il 1945 e dall'attuale acquisizione da parte di BlackRock sotto l'egida del nuovo cancelliere Merz.
I nazional-rivoluzionari tedeschi degli anni Venti e Trenta immaginavano, per uscire dalla morsa imposta dal trio occidentale, di unire le forze della Germania con quelle della giovane Unione Sovietica (in cui vedevano un nuovo avatar della Russia eterna), con la Cina del Kuomintang (sostenuta da consiglieri militari tedeschi, tra cui il generale Hans von Seekt). Evocavano una “triade tedesco-russo-cinese”, alla quale si sarebbero rapidamente unite un'India liberata dal giogo britannico, una Persia rigenerata dallo scià Pahlavi, la Turchia kemalista e i combattenti per l'indipendenza arabi (in particolare iracheni e siriani). Questa era, in realtà, la politica sostenuta da Primakov prima del suo tempo! Le dispute tra sovietici e cinesi, dopo la repressione anticomunista guidata dal Kuomintang, fecero sì che l'Unione Sovietica non prendesse più in considerazione alcuna partecipazione a una potenziale “triade” fintanto che ne facessero parte i nazionalisti cinesi. La presa del potere da parte di Hitler ridusse ulteriormente la possibilità di una tale Triplice eurasiatica. Le riflessioni e le azioni intraprese per realizzare una tale “Triade” furono studiate a fondo da uno studente che frequentava le lezioni di Jünger, Niekisch, Fischer e Paetel. Il suo nome era Otto-Ernst Schüddekopf (1912-1984). Egli scrisse un'opera copiosa su questo argomento, che gli autoproclamati “nazional-rivoluzionari” o “neo-destra” di Parigi e di altre parti non citano mai, non conoscono e non vogliono conoscere: Nationalbolschewismus in Deutschland 1918-1933 (Ullstein, 1960-72). Il rifiuto di qualsiasi subordinazione al trio occidentale è un'idea che Mohler avrebbe tradotto e aggiornato nei suoi Chicago Papers (scritti in inglese). Questo breve testo, sotto forma di una serie di brevi direttive, dovrebbe costituire il breviario di ogni europeo che desideri proteggere il proprio paese dai fastidi diffusi da Londra, Washington e Parigi (a meno che Parigi non torni alla politica gollista di indipendenza degli anni '60 che Mohler ammirava).
Il movimento “Völkisch” è stato studiato scientificamente solo di recente. È nato subito dopo la proclamazione dell'Impero tedesco nel 1871. Questa proclamazione ha portato la Francia a pagare ingenti danni di guerra, pari a 5 miliardi di franchi oro. Questo afflusso di capitali mal gestiti portò a una crisi finanziaria nel 1873, che scontentò notevolmente le classi medie meno abbienti e all'interno della quale nacquero alternative ideologiche che mescolavano nazionalismo e socialismo, sebbene in forme eterogenee, sempre mescolate ad altre correnti non politiche come il movimento di emancipazione giovanile, il neoruralismo, l'ecologia ante litteram e i movimenti di “riforma della vita” (nudismo, vegetarianismo, animalismo, antialcolismo, ecc.). Il movimento Völkisch non riuscì a creare un “pilastro” politico paragonabile alla socialdemocrazia o alla democrazia cristiana (Zentrum) o ad alcuni partiti liberali (anche il liberalismo era eterogeneo all'epoca). Il rifiuto del sistema che tuttavia servì da denominatore comune per tutte le iniziative Völkisch tra il 1871 e il 1914 si ritrova oggi nei movimenti populisti che si stanno affermando in tutta Europa, anche a causa di una crisi finanziaria dagli effetti irrisolti, quella del 2008. A questa crisi finanziaria si aggiungono altre crisi: morale, politica, migratoria, ecc. Lo studio del movimento Völkisch come protesta contro il sistema in vigore è quindi utile per comprendere il nostro tempo.
Lei ha incontrato Mohler di persona. Cosa ricorda di lui? Quale rapporto ha percepito tra la sua personalità intellettuale e il suo carattere individuale?
Il mio rapporto con Mohler era principalmente telefonico, come ho appena detto. Il primo contatto avvenne quando lavoravo a Parigi nella redazione di Nouvelle école, tra marzo e dicembre 1981: facemmo conoscenza e, la volta successiva, discutemmo di una nuova collana di libri, la “serie blu” pubblicata dalla casa editrice Herbig di Monaco con l'obiettivo di diffondere tesi nazional-rivoluzionarie insolite e anticonformiste (con un libro del teorico Henning Eichberg e la sintesi di una tesi di dottorato sul Niekisch di Uwe Sauermann). Nello stesso anno, in autunno, Mohler tenne una conferenza al castello di Laarne nelle Fiandre in occasione di un simposio organizzato dalla rivista Tekos: fu il nostro primo incontro di persona. Da notare: tra i partecipanti a questa giornata di studio c'era Edgard Delvo, ex segretario del teorico socialista e ministro belga Henri de Man, teorico del planismo che avrebbe influenzato il gollismo attraverso uno dei suoi discepoli, André Philip (che, da parte sua, non optò per una tregua con il potere tedesco dell'epoca).
Nel 1983 Mohler era a Parigi per un simposio del GRECE. Nel luglio 1984 ho fatto visita ad Armin Mohler nella sua casa di Monaco. Ho conosciuto sua moglie Edith, che ha sempre sostenuto le iniziative del marito con fedeltà e altruismo. Era anche l'incarnazione della gentilezza più perfetta. Quel giorno c'era un caldo torrido e tutti noi eravamo infastiditi da questa ondata di calore che, purtroppo, non incoraggiava lunghe conversazioni. Eravamo tutti abbattuti, senza energia. L'appartamento era pieno di libri, soprattutto libri d'arte, perché, oltre al suo costante interesse per la politica e la metapolitica, Armin Mohler era anche uno storico dell'arte molto acuto e uno specialista delle avanguardie e dei loro messaggi rivoluzionari, sia a livello politico-ideologico che estetico. È impossibile comprendere le ideologie del XX secolo senza tenere conto degli impulsi dati a intervalli regolari dalle avanguardie artistiche. Questo vale per la Germania con l'espressionismo, per la Francia con il surrealismo e le sue molteplici incarnazioni, per il Belgio e il movimento fiammingo con Wies Moens, Paul Van Ostaijen, Michel Seuphor e Marc Eemans. L'impegno politico primario di questi avanguardisti era molto spesso comunista, ma la loro successiva evoluzione li ha portati verso altri orizzonti, vari e diversi, ma sempre in rottura con il conformismo dei loro contemporanei e soprattutto con le banalità politiche dei partiti dominanti. Esattamente come il giovane studente Mohler, che era di sinistra all'inizio dei suoi tentativi metapolitici e di destra muscolosa per il resto del suo percorso ideologico.
In quel torrido giorno di luglio del 1984, Mohler mi portò nel seminterrato rialzato del suo palazzo dove conservava i gioielli più preziosi della sua biblioteca: copie originali, dedicate e/o molto rare. Mohler era anche un collezionista meticoloso.
Per quanto riguarda la sua personalità intellettuale, direi che era rigoroso nella ricerca, ma sempre didattico nelle spiegazioni o nelle esortazioni all'azione, e che aveva uno stile sempre incisivo. La sua preoccupazione era quella di far emergere le vocazioni, di portare le persone a scoprire l'essenziale nei testi sovversivi o radicali per far germogliare una nuova rivoluzione. Aveva certamente una conoscenza molto precisa del passato ideologico dell'area culturale germanica, ma non si impantanava in un passato specifico, qualunque esso fosse. Ho avuto l'opportunità di rispondere a un questionario che mi era stato sottoposto da Marc Lüdders, sui percorsi che Mohler ci suggeriva nelle colonne di Criticon, la rivista di Caspar von Schrenck-Notzing. Nessuno di questi percorsi faceva riferimento a fatti, personalità o eventi del passato, a parte il riferimento a Georges Sorel, autore che considerava essenziale, come riferimento obbligatorio: si può dire che Mohler fosse ancora più soreliano che “conservatore-rivoluzionario” (il termine “conservatore”, anche se a volte lo usava in modo eccessivo, non gli si addiceva davvero nel profondo). Vi fornisco queste risposte a Lüdders nell'appendice a questa intervista.
Mohler era attento alle idee correnti, nelle quali vedeva, spesso nonostante le apparenze, una continuazione della rivoluzione conservatrice jungeriana. Ciò è particolarmente vero nella definizione che ha dato, insieme a Wolfgang Welsch, della postmodernità. Il postmodernismo è diventato l'ideologia decadente attuale che affianca la pratica del neoliberismo in Occidente. Per Welsch e per Mohler, la postmodernità avrebbe dovuto diventare una corrente ostile all'ossificazione del liberalismo derivato dall'Illuminismo (e dal cartesianesimo, che anche i surrealisti volevano!). Oggi, senza aver mai consultato Mohler e Welsch, Aleksandr Dugin è d'accordo sulla stessa linea: dobbiamo creare, ci insegna, una posterità per la modernità che non sia il postmodernismo ufficiale, approvato dal sistema oggi in vigore, perché questo sistema ha prodotto il caos culturale e politico in cui è immerso l'intero Occidente, l'intera sfera americana. Con, come ciliegina sulla torta,
Per quanto riguarda i tratti caratteriali di Mohler, direi che era soprattutto un buongustaio (e un ghiottone), un amante della buona cucina francese, dei buoni vini della Borgogna o del Bordeaux e, come ho già detto, un appassionato collezionista di tutto ciò che riguardava i numerosi argomenti che affrontava.
Il fatto che Mohler fosse il segretario di Ernst Jünger ha influenzato il suo percorso intellettuale? Qual era il suo rapporto con Jünger, ma anche con altre figure della Rivoluzione Conservatrice?
Gli anni trascorsi con Jünger, tra il 1949 e il 1953, hanno sicuramente avuto un'influenza dominante su Mohler, anche se le sue idee di base erano già state sviluppate prima del suo arrivo nella nuova casa di Jünger a Ravensburg, vicino al Lago di Costanza (Bodensee), sulle cui rive viveva anche Friedrich-Georg Jünger. Come ho già detto qui, Mohler voleva far risorgere il movimento nazional-rivoluzionario degli anni Venti e Trenta, sviluppare una critica alla nuova Repubblica Federale che fosse virulenta quanto le critiche nazional-rivoluzionarie contro la Repubblica di Weimar, al fine di abbattere un regime concesso dagli americani, proprio come i nazional-rivoluzionari prima dell'era nazionalsocialista volevano distruggere un regime traballante, consegnato ai francesi, che chiedevano riparazioni, e agli americani, che si erano impadroniti delle leve dell'economia tedesca e criminalizzavano, in nome dei principi di Wilson, qualsiasi affermazione di sovranità o indipendenza (ma fu il Giappone la prima vittima dopo la sua conquista della Manciuria).
Mohler era senza dubbio un lettore di Carl Schmitt e aveva adottato principi come quello del “grande spazio” (europeo), il divieto per qualsiasi potenza al di fuori del mio spazio di intervenire in questo mio spazio (cioè il divieto di qualsiasi interferenza americana in Europa o in Asia), il primato della decisione nel processo politico, l'importanza dello stato di eccezione nella storia di un paese, ecc. Tuttavia, una volta ebbe l'occasione di dire che il sistema cattolico in cui Carl Schmitt navigava sempre gli era estraneo, proprio come gli era estraneo il sistema aristotelico-tomista di Thomas Molnar quando polemizzò con lui sulle colonne della rivista Criticon. Mohler è un “nominalista” (anche se la scelta del termine è infelice), cioè un esistenzialista eroico, nella misura in cui, al di là di tutte le certezze sostanziali a cui si aggrappano i cattolici, Mohler pensa che la volontà di un leader carismatico o di un'élite vigorosa possa cambiare il corso della storia: la sua visione della storia non è né lineare né ciclica. Egli non crede in un progresso inesorabile che marcia verso il futuro negando o dimenticando tutte le eredità del passato. Una tale marcia in avanti non è mai sostenibile e, prima o poi, sprofonda nella stagnazione e nel declino. Egli non crede nemmeno nel regolare ritorno dello stesso. La sua visione della storia è sferica: la sfera del tempo ruota su sé stessa e il leader carismatico o l'élite vigorosa possono, attraverso la volontà e il semplice esercizio del proprio potere, imprimere alla sfera una rotazione nella direzione di loro scelta. E aprire così un nuovo periodo nella storia di un insieme politico, nazionale o civilizzazionale. Fondando nuovi valori o rivalutando i valori logori dell'era precedente. Insomma, è la manifestazione di un nuovo “periodo assiale” che inizia così. Non ci sono quindi universali eterni, né generalità perenni. Mohler, qui, è nietzscheano: “Amor fati”.
Come è stato accolto il movimento della Rivoluzione Conservatrice al di fuori della Germania? Quali scambi ha avuto con le correnti in Francia e in Italia? Secondo lei, esiste ancora oggi un movimento che può essere definito “Rivoluzione Conservatrice”?
Per cercare di cogliere l'impatto della rivoluzione conservatrice al di fuori della Germania, bisogna prima sapere che la lingua tedesca era più conosciuta e praticata (almeno attraverso la lettura) prima del 1940 nella periferia scandinava, olandese/fiamminga, svizzera, ungherese, ceca, polacca, croata o slovena di quanto lo sia oggi, dove tutto è passato all'inglese. Allo stesso modo in Italia, l'interesse per le idee tedesche era reale prima del 1940 e, oggi, questo interesse è ancora più evidente nella penisola italiana che in altre parti d'Europa. Credo tuttavia che le grandi figure della Rivoluzione Conservatrice tedesca siano diventate dei classici in tutto il mondo: basta considerare il suo lavoro e sapere che i testi di Carl Schmitt sono ormai riferimenti imprescindibili nella nuova Cina di Xi Jinping. Mohler una volta disse che quattro quinti degli autori che citava nella sua tesi sulla Rivoluzione Conservatrice sono oggi dimenticati o non hanno più alcuna rilevanza. Questo è vero. Ma i grandi classici sono più importanti che mai nei dibattiti fondamentali: Jünger, Spengler, Schmitt, Haushofer sono pensatori essenziali e hanno conservato tutta la loro virulenza quando si tratta di contestare il sistema. Appartenevano al campo dei vinti, ma i vincitori non sono stati in grado di mantenere in buono stato il sistema che hanno messo in atto. Questo sistema sta affondando, imbarcando acqua da tutte le parti, soprattutto dopo la crisi del 2008. I rimedi del quartetto che ho appena citato sono le ricette adatte a porre rimedio ai fallimenti dell'americanismo liberale e a passare a una vera postmodernità, come immaginavano Mohler e Welsch e come immagina oggi Dugin.
Mohler fu corrispondente per diversi giornali tedeschi e svizzero-tedeschi in Francia dal 1953. Rimase a Parigi per quattro o cinque anni. Nel 1963, anno in cui iniziò la riconciliazione franco-tedesca con l'incontro tra De Gaulle e Adenauer a Colombey-les-deux-Eglises, residenza secondaria del presidente francese, fece una valutazione delle sue successive osservazioni sul gollismo. Mohler scrisse una seconda tesi di dottorato sulla Francia di De Gaulle, che gli permise di scrivere un libro straordinario per il grande pubblico in cui accoglieva con favore lo spirito di indipendenza e sovranità della Francia negli anni '60, dopo i tumulti e gli sconvolgimenti del conflitto algerino (si veda Die Fünfte Republik. Was steht hinter de Gaulle?, Piper, Monaco, 1963). Mohler scommise su una Francia gollista in un momento della storia recente della Francia in cui la destra era comunque molto ostile al presidente e in cui la militanza nazionalista aveva assunto la forma dell'OAS (Organisation de l'Armée Secrète), un'organizzazione clandestina che aveva organizzato numerosi attentati in Algeria e nella Francia metropolitana e che poi aveva tentato di assassinare De Gaulle. Molti leader della “nuova destra” provenivano dall'OAS o dal movimento che simpatizzava con questa organizzazione. Mohler era quindi in contrasto con loro. Da Jünger ereditò un rifiuto sistematico degli attentati contro personalità politiche di spicco. Jünger aveva sconsigliato l'attentato a Rathenau (al quale aveva partecipato Ernst von Salomon) e aveva giudicato pericoloso quello orchestrato da Claus von Stauffenberg (alla cui famiglia era vicino) contro Hitler. Mohler disapprovava quindi l'attentato a De Gaulle secondo la stessa logica.
In Italia, purtroppo, i legami tra Mohler e le innumerevoli personalità italiane che avrebbero potuto essere sulla sua stessa lunghezza d'onda mi sembrano stati molto labili, se non inesistenti. È un peccato perché il terreno sembra più fertile in Italia che in Francia, dove la doppia coltre del giacobinismo e della sinistra selvaggia è molto più pesante e dove, oggi, una repressione molto più insidiosa che in qualsiasi altro paese europeo si abbatte sul non conformismo, che è in fase di riorganizzazione e di controffensiva.
In che misura la linea intellettuale tracciata da Mohler ha influenzato il pensiero contemporaneo di destra?
Recentemente, un amico tedesco mi ha confidato di essere scettico riguardo alla posterità di Mohler: con grande tristezza nella voce, ha lamentato che questo polemista politico fosse stato completamente dimenticato nella nostra epoca di declino intellettuale, crollo dei sistemi scolastici e wokeismo onnipresente. Questo è in parte vero, con l'eccezione del piccolo gruppo riunito attorno alla rivista Sezession, diretta da Götz Kubitschek (che aveva pronunciato un elogio funebre sulla tomba di Mohler al suo funerale) e sua moglie Ellen Kositza, con il prezioso aiuto del dottor Lehnert. Questo team ha pubblicato raccolte di testi inediti o opere fuori stampa di Mohler, molto preziose per conoscere la sua biografia e il contesto svizzero e tedesco in cui sono emerse le sue azioni. Esistono certamente dei legami tra questo gruppo di Sezession e alcuni elementi dell'AfD, ma questi legami sono, come al solito, soggetti ai capricci e agli shock di una vita politica estenuante e sono gravati dal costante opprobrio orchestrato dai “vecchi partiti” e dai teppisti isterici del panorama mediatico tedesco e straniero.
Per trarre i rimedi per un possibile rinnovamento politico ispirato a Mohler e agli autori conservatori della rivoluzione che ha studiato, sarebbe necessario, a mio avviso, rileggere in modo critico (nel senso greco e filosofico del termine) il suo libro sulla Francia degli anni '60, dove una figura singolare (in questo caso quella di De Gaulle) determinava la via da seguire piuttosto che parlamenti composti da imbecilli, buffoni da bar, avvocati disonesti o personaggi squilibrati. Attorno a una tale personalità, dovrebbero essere costituiti team misti (composti da anticonformisti di destra e di sinistra), esposti a tutti i dibattiti ideologici, capaci di soppesare i pro e i contro, per iniettare nuova linfa nelle società scosse dall'incompetenza dei “liberali” (nel senso di Mohler e del vocabolario usuale dei paesi anglosassoni). De Gaulle, inoltre, voleva una rappresentanza diversa da quella di un parlamento di deputati di partiti incoerenti: suggeriva un Senato delle professioni e delle regioni, con rappresentanti del mondo reale, della gente concreta.
Ancora più importante, dovremmo meditare e interiorizzare il contenuto dei Chicago Papers, riprodotti nel suo volume Von Rechts gesehen (“Visto dalla destra”). Anche dopo 52 anni di attività all'interno delle «nuove destre» europee, ma soprattutto di quelle francofone, mi stupisce constatare che questi Chicago Papers non costituiscono o non costituiscono più l'ABC fondamentale delle destre metapolitiche e politiche in termini di politica estera o politica europea. Non sono mai stati tradotti e diffusi in francese, italiano o spagnolo. I cosiddetti “mohleriani” della “nuova destra” (soprattutto quella parigina) li hanno sistematicamente ignorati: si può capire che abbiano mal sopportato il libro sulla Francia degli anni '60, visti gli eventi in Algeria e le attività dell'OAS. Ma, non appena è apparsa l'opzione antiamericana con la pubblicazione del numero di Nouvelle école sull'America nel 1975 (la cui stesura è stata curata principalmente dal filosofo italiano Giorgio Locchi) e del numero di Éléments intitolato “Per porre fine alla civiltà occidentale” (scritto sotto l'impulso di Guillaume Faye), i Chicago Papers avrebbero dovuto servire da bussola per tutti gli attivisti impegnati in questa lotta metapolitica o in altre attività dello stesso tipo. Si tratta di un testo molto breve, il cui contenuto è facile da assimilare. Permette di separare il grano dal loglio, di non farsi più ingannare dalle false “verità propagandistiche” martellate tutto il giorno nella sfera americana e nei media ufficiali.
Per Mohler, il gollismo ha attraversato quattro fasi, l'ultima delle quali è la più interessante, la più fertile per il futuro: la fase della “Grande Politica”, con una geopolitica globale alternativa articolata in particolare durante il discorso di Phnom Penh del 1966, un periodo in cui la Francia cercò di liberarsi dalla morsa americana lasciando il comando della NATO, senza esitare a stringere alleanze con Stati considerati “canaglia” (la Cina, per esempio), e assumendo una politica indipendente in tutto il mondo, che consisteva, ad esempio, nella vendita di aerei Dassault Mirage all'Australia e al Sud America, in diretta concorrenza con i produttori americani di cacciabombardieri. Questa “Grande Politica” si interruppe nel maggio 1968, quando l'‘anarchia’ si manifestò e iniziò la sua “lunga marcia attraverso le istituzioni”, che portò la Francia direttamente alla grande farsa festosa dell'epoca di Sarközy e Hollande, al decadimento totale e al delirante wokeismo sotto Macron. Il maggio 1968 fu davvero una “rivoluzione colorata” ante litteram.
Mohler, non come lettore di Jünger ma come lettore di Schmitt, è un gollista, proprio in nome dei principi della sua rivoluzione conservatrice. Non capisce come si possa non giudicare De Gaulle solo sulla base dei criteri schmittiani. Commenta l'avventura degli ultras dell'OAS in due righe. Mohler apparteneva quindi a un terreno politico diverso da quello dei futuri leader della “nuova destra” (ND). La nuova destra tedesca ha altre idiosincrasie: la convergenza tra Mohler e la ND francese (con il jungeriano Dominique Venner) sarebbe arrivata più tardi, quando le divisioni della guerra d'Algeria non avevano più rilevanza politica diretta.
Mohler voleva trasporre l'indipendentismo gollista in Germania. Nel febbraio 1968 si recò a Chicago per difendere il punto di vista della “Grande Politica” gollista in un “Colloquio euro-americano”. Il testo del suo intervento, scritto in inglese e mai tradotto in francese (!), ha il merito di essere programmaticamente chiaro: egli voleva, sotto le insegne di un nuovo gollismo europeo, liberare l'Europa dalla camicia di forza di Yalta, senza però avvelenare le relazioni con l'URSS.
I Chicago Papers chiedono quindi di dialogare con gli Stati che gli americani designano come “Stati canaglia”. Si dedurrà, nel contesto attuale, che qualsiasi Stato designato come tale da Washington dovrebbe essere considerato un potenziale alleato o un valido partner commerciale. Qualsiasi guerra, boicottaggio o politica di sanzioni contro tali Stati deve essere respinta. Nella situazione attuale, in cui gli Stati del gruppo BRICS o gli Stati emergenti come l'Indonesia o anche il Messico hanno il vento in poppa per affermare la loro piena sovranità, l'interesse di tutti gli Stati europei è quello di mantenere relazioni positive con loro. Al contrario, ciò che viene elogiato come positivo dagli Stati Uniti dovrebbe automaticamente suscitare un profondo scetticismo. Pertanto, tutte le esortazioni di Bernard-Henri Lévy dovrebbero indurre tutti gli Stati europei ad adottare politiche diametralmente opposte. Dovremmo fare esattamente l'opposto di ciò che sostiene Lévy.
L'ultima ondata di reminiscenze di questa “grande politica” gollista si è manifestata nell'ostilità comune della Francia di Chirac, della Germania di Schröder e della Russia di Putin nei confronti delle operazioni anglo-americane in Iraq nel 2003. L'asse Parigi-Berlino-Mosca avrebbe fatto piacere a Mohler e avrebbe suscitato qualche speranza proprio nell'anno della sua morte. Questo asse piaceva anche a Jean Parvulesco, ispiratore di Dugin e altro propagandista della “grande politica” di De Gaulle.
Come interpretare l'eredità di Mohler – e più in generale della Rivoluzione Conservatrice – nel contesto delle attuali crisi geopolitiche (la guerra in Ucraina, la rivalità sino-americana, i dibattiti sull'indipendenza strategica dell'Europa)?
L'eredità pratica di Mohler risiede in quei Chicago Papers che ho appena citato. Nel 1980, sulle colonne di Criticon, Mohler presentò due autori fino ad allora dimenticati, che venivano riscoperto anche a livello scientifico e che, pochi mesi prima, non avrebbero avuto posto in una rivista etichettata come “conservatrice”: Ernst Niekisch, l'attivista nazional-bolscevico, e Karl Haushofer, il geografo che si suicidò nel 1946. Ero ancora uno studente, stavo finendo gli studi e il lavoro accademico da completare si accumulava sulla mia scrivania, ma li tradussi immediatamente per il bollettino GRECE-Bruxelles. Niekisch e Haushofer sarebbero stati autori guida per me per tutta la vita, grazie a Mohler. Naturalmente, ancora oggi questi autori costituiscono riferimenti essenziali in molti circoli metapolitici e geopolitici italiani, in Russia sulla scia di Dugin, o anche negli uffici cinesi dove si sta delineando la politica della nuova Cina di Xi Jinping.
Durante la vita di Mohler non ci fu alcuna crisi ucraina. Fu solo un anno dopo la sua morte, nel 2004, che scoppiarono i primi disordini a Kiev, con la “Rivoluzione arancione”. Per comprendere in modo intelligente gli eventi in Ucraina, Crimea e Donbass, il geografo più interessante da studiare rimane Richard Henning (1874-1951), autore di un'opera molto copiosa, Geopolitik – Die Lehre vom Staat als Lebewesen. Henning ha sviluppato una Verkehrgeographie, una geografia degli assi di comunicazione terrestri, estremamente interessante in un momento in cui la Cina intende perseguire il suo progetto “Belt and Road Initiative” e dove si stanno prendendo in considerazione altri progetti continentali, come l'INSTC tra Bombay e il Baltico attraverso il Caucaso, nonché progetti alternativi immaginati dalle potenze talassocratiche anglosassoni, come il corridoio che dovrebbe condurre alle coste israeliane o addirittura al livello delle rovine di Gaza, una città sradicata per realizzare questo progetto in apparenza. Il corridoio di Zangezur o “corridoio di Trump” è un'altra iniziativa occidentale molto recente, ma anch'essa, qualunque cosa si possa dire, rientra nella logica dell'organizzazione dei territori e delle comunicazioni continentali. Mohler, a quanto pare, non ha studiato le opere di Henning. Quest'ultimo non era politicizzato, sebbene fosse un patriota clausewitziano (si vis pacem, para bellum), ma dovette comunque rinunciare alla sua cattedra in Germania, poiché la geopolitica non era più ben vista sotto l'occupazione americana (che è ancora in corso). Tuttavia, continuò brillantemente la sua carriera in Argentina e fu la forza trainante di importanti opere infrastrutturali in Sud America.
La rivalità sino-americana è menzionata nei Chicago Papers, poiché la Cina di Mao è presentata come uno “Stato canaglia” che gli americani vogliono isolare dal resto del mondo. Ma questo era prima che la diplomazia di Kissinger risolvesse la disputa tra Pechino e Washington a vantaggio di entrambe le parti nel 1972. La Cina, come per magia, non era più uno “Stato canaglia”, ma un interlocutore comprensivo, mobilitabile contro i “cattivi russi”. Oggi, sia la Russia che la Cina sono considerate Stati nemici.
Per quanto riguarda i dibattiti sull'indipendenza militare, diplomatica, energetica e strategica dell'Europa, essi sono attualmente inesistenti o relegati in oscuri margini dove autori rilevanti ma poco conosciuti ne discutono, più o meno banditi dai media, dalla televisione o dall'editoria. I dibattiti erano più visibili negli anni '80, quando Gorbaciov annunciò la sua perestrojka e la sua glasnost. Poi, quando iniziò a parlare di una “Casa comune”. In Germania, non appena sono iniziate le grandi manifestazioni contro il dispiegamento dei missili americani, numerosi circoli hanno ricominciato a parlare di neutralità (per tutti i paesi della Mitteleuropa) o di un riavvicinamento tedesco-russo. Sotto Eltsin, questi dibattiti sono prima svaniti, poi sono tornati vividi quando la NATO ha iniziato a bombardare le città serbe nel 1999. Ci fu poi una svolta teatrale in Germania, quando i Verdi, che facevano parte del governo, abbracciarono la causa della NATO, sotto l'impulso di Joschka Fischer, il ministro degli Esteri: Fischer proveniva dalla sinistra radicale, che, proprio in un'epoca precedente, aveva criticato con virulenza l'imperialismo americano. Mohler fu quindi più coerente dei folkloristici e violenti esponenti della sinistra che furono pronti a tradire gli ideali della loro giovinezza. Il passaggio dei Verdi a un bellicismo eccessivo è sorprendente e provoca uno sgomento ulteriormente amplificato dalla patologica russofobia della recente ministra verde Annalena Baerbock, che intendeva promuovere una “politica estera femminista”. Tutto ciò è diametralmente opposto alle proposte avanzate da Mohler durante la sua carriera metapolitica e politica.
In Occidente assistiamo oggi all'egemonia culturale americana, al calo dei tassi di natalità, alle chiese vuote e al “wokeismo” che ridefinisce le norme sociali... Di fronte a questo quadro, ritiene davvero possibile produrre una nuova forma di vita, una nuova sintesi politico-culturale? E se sì, su quali basi potrebbe essere costruita?
Nella cerchia di Mohler, fu soprattutto Caspar von Schrenck-Notzing a criticare aspramente l'egemonismo americano sulla Germania dopo il 1945, nel suo libro Charakterwäsche. Die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen (Seewald, Stoccarda, 1965 – diverse edizioni successive da parte di vari editori). Caspar von Schrenck-Notzing spiegava che la “rieducazione” voluta dalle autorità di occupazione americane aveva completamente sterilizzato il carattere nazionale tedesco, impedendo l'emergere di una politica stabile e fertile per il centro dell'Europa. Il libro è ormai un classico per comprendere il dopoguerra tedesco.
I problemi di natalità, sebbene importanti, erano appena accennati da Mohler. Non essendo né cattolico né protestante, Mohler non si preoccupava dello svuotamento delle chiese. Tuttavia, a volte gli piaceva definirsi un “kathol”, ovvero una persona che condivideva le stesse posizioni politiche dei circoli cattolici, come Carl Schmitt, senza essere interessato alla vita religiosa e parrocchiale o ai problemi teologici.
Ai tempi di Mohler non si parlava di wokeismo. Tuttavia, come tutti gli uomini di destra, era sensibile ai tormenti del declino e della decadenza, che per lui erano il risultato di un liberalismo ormai superato, impazzito negli Stati Uniti, timidamente impiantato in Europa nel periodo tra le due guerre e deliberatamente dopo il Piano Marshall. Il liberalismo è un'“idea generale” secondo Mohler, che porta al quietismo politico in un'atmosfera consumistica: a questo liberalismo morbido, a questo liberalismo precedente al neoliberismo più aggressivo, era necessario, diceva, opporre il mito, alla maniera di Sorel. Il nuovo mito, se mai nascerà, sarà l'unico in grado di salvarci: Mohler non credeva in una “sintesi intellettuale”, in un sistema concettuale rigorosamente costruito, alla maniera di Hegel, che avrebbe una risposta razionale per tutto. Tali costruzioni sono sterili e non smuovono le persone. Il mito mobilitante, che dà un impulso assiale, fa girare la sfera della storia in una nuova direzione e sarà l'unico fertile. Questo mito dovrebbe sempre avere un supporto visivo accattivante, bello e suggestivo, simile al muralismo messicano (al quale ha dedicato un testo di grande interesse) o agli affreschi murali irlandesi o ai manifesti della Cina di Mao.
Personalmente, essendo un lettore di Mohler da quando avevo diciannove anni, credo che la soluzione ai mali dell'Europa potrà venire solo da un ritorno al classicismo, un classicismo veicolato da immagini nuove e forti, mitizzate secondo criteri che gli artisti svilupperanno quando sarà il momento giusto, per aprire la strada a personalità forti che influenzeranno il corso delle cose, della res publicae. Perché il tempo è sferico, non lineare e non ripetitivo/ciclico, come ha spiegato Mohler nell'introduzione all'edizione del 1989 della sua tesi sulla “Rivoluzione conservatrice” tedesca.
Traduzione di Costantino Ceoldo